|
SECONDO I DATI forniti dall'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni
(OIM) e diffusi nel febbraio del 2001, ci sono oggi nel mondo quattro
milioni di vittime della tratta di esseri umani, di cui l'ottava parte
- circa mezzo milione - nell'Europa occidentale. Si tratta di «movimenti
e vendita illecita di persone tra paesi e continenti contro un compenso
finanziario o di altro tipo». Questo traffico genera ogni anno
profitti che si possono stimare compresi fra i sette e i tredici miliardi
di dollari (Afrique.
Le trafic d'êtres humains s'amplifie,
in «ANB-BIA», Africa News Bulletin - Bulletin d'Information
Africaine, n.408, 22.02.2001).
Se questa è la nuova schiavitù, su cui si sa poco e di cui si rimuove
troppo, la nebbia scesa sulla tratta di esseri umani degli ultimi
cinque secoli si va diradando. È stato calcolato, per esempio, che
nel periodo tra il 1450 e il 1870, dai dodici ai quindici milioni
di schiavi africani hanno passato l'Atlantico in catene, sulle navi
europee e americane. Per Doudou Diène, che dal 1994 coordina da Parigi
il progetto UNESCO The Slave Route, ogni sforzo fisico o mentale,
anche individuale, che contribuisca a recuperare la memoria dei luoghi
e dei simboli fisici della tratta, è un atto di rilevanza etica, che
punta a un futuro di dialogo tra le culture, i popoli e le civiltà.
La ricostruzione storica e la versione a fumetti dell'ultimo viaggio
della Fredensborg, naufragata nello Skagerrak nel 1768, sono il frutto
di una ricerca di gruppo partita da un atto individuale, epico ed
etico insieme. Da più di un quarto di secolo, con la meticolosità
di un piccolo Schliemann e la deter-minazione di un Amundsen, un norvegese
si va dedicando alla vicenda di questa nave, metafora della storia
sommersa, per raccontarla all'umanità. Leif Svalesen era poco più
di un ragazzo quando gli capitò di leggere due o tre righe sulla Fredensborg
in un libro di storia costiera del suo paese. Nel 1974, messosi alla
ricerca del relitto con Tore Svalesen, suo fratello, e l'amico Odd
Keilon Osmundsen, lo individuò a poca profondità, tra gli scogli dell'isola
di Tromøy presso Arendal. Nel corso degli anni, accompagnando il lavoro
degli archeologi, ha studiato la vicenda dell'ultimo viaggio della
nave negriera attraverso le carte del capitano e dell'assistente di
bordo, salvatisi con tutto l'equipaggio; e ha riscontrato sul campo,
per quanto possibile, gli elementi raccolti sott'acqua e negli archivi
danesi.
Dallo Skagerrak alla Costa d'Oro ai Caraibi e ritorno, sulla rotta
triangolare di una fregata stivata all'inverosimile di merce sempre
diversa per ogni lato del triangolo, con gravi rischi per tutti gli
uomini a bordo ed enormi guadagni per la Compagnia, salvo i disastri.
Nel lato transatlantico del triangolo, dalla Costa d'Oro alle Isole
Vergini, la merce erano gli schiavi, l'oro, l'avorio.
| |
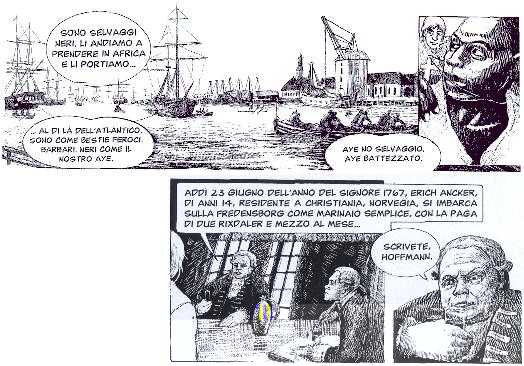 |
|
DALLA MONOGRAFIA DI SVALESEN è nata la storia a fumetti, raccontata
dal punto di vista di uno dei testimoni: il marinaio semplice Erich
Ancker, di Christiania, digiuno di traversate, imbarcatosi a Copenhagen
il 23 giugno 1767, scampato al naufragio il primo dicembre 1768, a
poche decine di leghe da casa. Un'odissea di diciotto mesi. La storia
illustrata di Erich e degli schiavi della Fredensborg, vignetta per
vignetta, si ispira ai materiali del relitto, ai dati d'archivio e
alle ricerche storiche, archeologiche e antropologiche: edita in norvegese
nel 1996 con la consulenza di Svalesen, è uscita in inglese nel 1998,
contemporaneamente al film di Spielperg «Amistad».
Tra la Fredensborg, nave negriera di una Compagnia danese-norvegese,
e la Amistad, malandata carretta di un avventuriero spagnolo, ci sono
settant'anni di tratta atlantica e di storia dell'umanità. Nel 1839
la Amistad aveva imbarcato all'Avana una cinquantina di africani che
un negriero portoghese aveva deportato a Cuba dalla Sierra Leone,
dopo che gli accordi tra la Spagna e l'Unione degli Stati americani
avevano ufficialmente messo fine alla tratta. Gli schiavi si ribellarono
e si impadronirono della nave in modo cruento. Catturati dalla guardia
costiera del Connecticut, processati e assolti perché riconosciuti
titolari del diritto di aspirare alla libertà, tornarono in Africa.
Gli schiavi della Fredensborg, invece, su cui vigeva una disciplina
di ferro, erano stati imbarcati nelle acque della Costa d'Oro nel
1768 da una fregata rimessa a nuovo e "con le carte in regola", che
si appoggiava ai forti costieri dei possedimenti danesi della regione
del Volta. Di lì a pochi anni, nel 1772, una sentenza inglese condannò
per la prima volta la schiavitù, per ragioni umanitarie e per ridimensionare
il vantaggio economico di chi acquistava gli schiavi e li impiegava
nelle piantagioni d'oltremare o in altre attività produttive. La Fredensborg
è la nave negriera più documentata tra quelle di cui si è ritrovato
il relitto. L'UNESCO ne ha fatto uno dei punti forti del suo progetto
educativo internazionale TST (The Translatlantic Slave Trade).
La traduzione italiana del fumetto di Kurt Aust, Leif Svalesen e Kin
Wessel è il contributo offerto al progetto TST da una piccola scuola
superiore trentina con tre indirizzi di studio: l'Istituto «Martino
Martini» di Mezzolombardo, che fa parte della ASPnet, la rete
internazionale di scuole associate all'UNESCO. L'attività di traduzione
e di studio è stata svolta nell'anno scolastico 2000/2001, il primo
di piena autonomia delle scuole italiane, all'interno dei programmi
di lettere e lingua straniera. È stata affidata a quattro classi seconde
- due di indirizzo liceale scientifico, una di indirizzo tecnico commerciale,
una di indirizzo professionale - come lavoro individuale e di gruppo,
coordinato dagli insegnanti e assistito dai tecnici scolastici ed
editoriali. Uno sforzo finalizzato a questo prodotto.
Che un progetto educativo si traduca in una pubblicazione per il mercato
alla quale partecipano gli studenti non è una novità. Ogni esperienza
educativa, d'altra parte, è unica e non riproducibile. Di riproducibile,
in educazione, c'è solo il metodo: l'impostazione del progetto e della
rete di relazioni - tra le persone, gli enti, i luoghi, le fonti -,
l'analisi dei tempi e delle risorse, la programmazione didattica,
l'osservazione, la registrazione, la verifica, la condivisione dei
risultati, l'organizzazione della memoria umana e tecnologica.
Forse non c'era neppure bisogno di dirlo: la procedura, riproducibile,
è una forma da sottintendere, non da invocare a ogni passo. L'errore
in cui spesso incorriamo come educatori, nella procedura, è invece
di dare a quest'ultima l'enfasi, lo spazio e la valenza che dovremmo
riservare al risultato.
|